-
Venticinque anni perduti a rincorrere il vento

La nostra insicurezza ci pone dinnanzi ad un tormento senza fine che Fabrizio De André riassunse in un quesito semplice e asciutto: “Come potrò dire a mia madre che ho paura?”Ecco, dentro a questa frase che culmina con un lancinante punto interrogativo è condensata l’amletica e sempiterna drammaticità della questione morale, etica e generazionale. Vi risiede il seme della discordia verso se stessi, la contrapposizione tra l’Io insicuro e l’Io risoluto, l’Io laico e contemporaneo contro l’Io bigotto e conservatore; l’ipocrisia verso lo scandalo; la certezza di non saper niente; l’immanenza del rapporto genitoriale; la fiducia materna che si incrina nel momento stesso in cui si ha “paura di aver paura”.Con che faccia confrontarsi con il mondo?Fabrizio De André, che ci ha lasciati proprio in Gennaio, nel 1999, poneva sempre l’ascoltatore davanti ad una scelta: in ogni suo verso ci insegnava il senso di responsabilità.Confessore di se stesso, giudice senza giudicare, egli incarnava il gesto poetico con l’ardore di un rivoluzionario.Si autodefiniva soltanto “cantautore” perché, ricordando le parole di Benedetto Croce, “fino all’età dei diciotto anni tutti scrivono poesie. Dai diciotto anni in poi, rimangono a scriverle due categorie di persone: i poeti e i cretini. E quindi io precauzionalmente preferirei considerarmi un cantautore” , ma ciò non impedisce a chi oggi ascolta ogni parola, frase, brano, battuta, riflessione di Faber, di capire quanto si sbagliava per un eccesso di umiltà che l’ha caratterizzato fin da giovanissimo, fin dai tempi della detestata “carriera scolastica” negli istituti privati del padre, fin dalle prime esibizioni tragicomiche e caustiche con l’amico di una vita, Paolo Villaggio.Paolo, che gli disse quanto era stronzo a porsi come un turbolento e volgare ragazzo arrabbiato col mondo. Paolo, che gli consigliava di misurarsi davanti al pubblico di merda che gli stava davanti. Paolo, che per primo fu al suo funerale, perché fra merdacce si capivano bene.Perché anche la vita di De André era poesia, o forse lo è per tutti ma solo un poeta può cogliere certe analogie, certe figure, certe suggestioni, e rendere tutto lirico, un omaggio all’esistenza.Come i poeti latinoamericani del Novecento: Neruda, Huidobro, De Rokha, i creazionisti, la vita di Fabrizio fu un’avanguardia poetica che celebrava la poesia dovunque, anche per la strada e nella miseria umana, la sua ambientazione preferita.Mentre le sue canzoni, avvolte in un linguaggio superbo e dal sapore antico, erano permeate da un’ideologia e una potenza politica da andare oltre alla politica stessa.Faber era anarchico, non è mai stato un segreto.Eppure era spirituale, autentico, agreste, classicista, esteta, impaziente, individualista, libertario, scomodo, infedele, egocentrico e realista.E’ una cosa possibile? Ma certo, se sei De André, naturalmente. Chiunque altro sarebbe soltanto uno sputtanato inconcludente e poco consapevole.Se la canzone italiana ha un qualche valore, una certa cifra artistica, è indubbiamente merito della generazione di cantautori “arrabbiati” che hanno calcato le scene dalla metà degli anni sessanta fino alla fine degli anni di piombo; la coincidenza storica tra il grande casino sessantottino, le stragi, l’inquietudine, gli scioperi, i compromessi più o meno storici, e l’arte.Pasolini, Pannella, Berlinguer, Pazienza, Fellini, Malerba, Zanzotti, Calvino, Pinelli, Fo, Volonté, eccetera, eccetera, eccetera…poeti, scrittori, registi, attori, saggisti, attivisti; si aggiunsero, come accadeva in tutto il resto del mondo, anche i cantautori. O meglio sorsero, perché prima, caso curioso, non c’erano. C’erano i menestrelli, gli aedi, i cantori di strada, gli interpreti, i poeti, ma non sussisteva la categoria.Fu così che spuntarono, tra Genova, Bologna, Milano e Roma: Dalla, Guccini, Bertoli, Graziani, Lauzi, Battiato, De Gregori, Venditti, Vecchioni, Paoli e il diversissimo Fabrizio De André.Perché le sue battaglie erano intime. Perché i suoi spettacoli erano trasversali. Perché le sue giornate erano su un trattore, in Sardegna, lontano da tutto e da tutti.Perché la sua situazione era spinosa, scomoda, una vita fatta di un vissuto che permeava tutto se stesso, anche tutto ciò che scriveva. Soprattutto ciò che scriveva.Fabrizio era anarchico dalla mattina alla sera, dalla veglia al sonno, probabilmente anche mentre sognava.La differenza sta tutta lì.E oggi, la sua mancanza è un baratro così grande da risultare incolmabile e ogni giorno abbiamo un disperato bisogno di ascoltare le sue parole, per la necessaria condizione umana che in questo torpore manca terribilmente: REAGIRE.
-
Viva Ken Kutaragi // 30 anni di Playstation

Attenzione:
Questo articolo contiene informazioni e linguaggio altamente nerd, ma non quei fighetti contemporanei con le sneakers da Trecento Euro e le magliette delle Marvel che citano Star Wars in modo blasfemo e che confondono Mazinga con Goldrake. No, ci riferiamo ai quarantenni e cinquantenni che all’epoca in cui sono narrati i fatti in oggetto erano giovani disadattati che al disagio dell’esistenza preferivano l’esperienza sensoriale videoludica e incoraggiavano la propria emarginazione con profondo senso di disperazione frammisto a visioni spasmodiche di Akira.Dapprima fu Toshinden. Fummo investiti da un’ondata di impossibile che si faceva concreta materia. Un videogioco picchiaduro in tre dimensioni, poligonale, con visuale a trecentosessanta gradi, laddove l’uso dell’arma bianca causava ferite permanenti nei personaggi utilizzati. Forse era solo uno scherzo, una burla di chi aveva visto le anteprime a San Diego o Tokyo e portava in Italia notizie ingigantite dall’entusiasmo e dalla brama di vendite. E invece, quel che potemmo assaporare sulle pagine di Super Console, Console Mania e sulla neonata PSM, era pura realtà. Purtroppo, il giudizio è impietoso: Toshinden si rivelò un pastrocchio ingiocabile e di impossibile fruizione per un occidentale, ma l’effetto visivo fu di un impatto colossale, irripetibile e – a tutti gli effetti – irripetuto.
Ciò che contraddistingue l’arrivo, nel 1994, della Sony Playstation, è stato il senso di stupore che esso generò nelle menti e negli occhi di giovani e meno giovani. È noto come nessuna altra console di generazione successiva sia riuscita a ricreare quel sense of wonder che sbaragliò un’intera massa di videogiocatori. Perfino le tanto agognate “Next Gen” del 2023/24, le novità assolute, di “next” hanno solo il nome: manca l’anima e soprattutto manca quel vero e proprio salto in avanti che fu introdotto al tramonto delle console a 16 bit, al cospetto dell’arrivo di quell’oggetto che oltrepassò i confini del “giocattolo” e si trasformò in vero e proprio “entertainment system” a tutto tondo.
I primi titoli che i fortunati adolescenti dell’epoca poterono giocare, furono per l’appunto una nuova frontiera del divertimento; attenzione, non soltanto a livello grafico e interattivo, questo è il dato forse più lampante ma non l’unico elemento di emozione. I giochi della PlayStation erano maturi, potremmo dire senza età, perché furono i primi ad avere una colonna sonora con musica vera, suonata da artisti internazionali e famosi (una parola su tutte: Wipeout, con la colonna sonora house/techno/dub che ancora oggi si può definire senza rivali, con Prodigy, Fluke, Chemical Brothers, Future Sound of London, ecc.) , furono pure i primi a rivelarsi simulazioni sportive senza precedenti (qualcuno ha detto Gran Turismo?) , con autovetture reali, calciatori reali, piloti reali, cestisti reali, giocabili in un ambiente ricreato con una mappatura che all’epoca poteva davvero essere confusa con la realtà. Gli stadi, i circuiti, tutta l’esperienza virtuale era calata in una sorta di verità alternativa che all’occhio dell’autentico nerd rappresentò quella via d’uscita, quell’occasione, che nel tangibile, nel quotidiano, mancava puntualmente all’appello.
Ma sapete, è piuttosto evidente che al geek anni Novanta facesse gola un prodotto del genere; quello che sorprese fu quanto la videoludica travalicò i confini degli appassionati e si impose con prepotenza all’interno di tutte le case, diventando un hobby, una moda, una tendenza di massa e di largo consumo.
A conti fatti, dopo trent’anni, è possibile affermare che l’avvento di Sony PlayStation sia stata un bene per l’uomo? Che sia azzardata come affermazione? Valutiamo soltanto questo: di una lavatrice o di un giradischi, non avremmo alcuna vergogna nell’affermare che siano state creazioni capaci di migliorare la vita quotidiana. Perché non dirlo della Play, allora?
Di sicuro ebbe meno conseguenze negative degli smartphone e dei social… -
1954//2024: 70 anni di TV in Italia

Il 2024 sarà un anno da guardare attraverso la prospettiva della comunicazione e delle cosiddette rivoluzioni digitali. No, non ci stiamo riferendo al machine learning o al destino dei social network, niente di così orientato verso il futuro, anzi: stiamo parlando di ricorrenze.
Quest’anno si celebrano i settant’anni della tv in Italia e i trent’anni dall’avvento nei negozi del Bel Paese della Sony PlayStation.
Con il senno di poi, entrambe le tecnologie hanno avuto un impatto transgenerazionale di enorme portata, ben aldilà delle attuali perplessità relative a ciò che il comparto digitale porterà con sé nel futuro prossimo venturo.In data 3 Gennaio 1954, uno scatolone di legno al cui interno era incorniciato un vetro bistondo iniziò a proiettare su di esso immagini in movimento dotate di suono in presa diretta; tutto ciò emesso da un tubo – detto “catodico” – di cui ancora oggi sfido ingegneri e informatici a spiegarci il funzionamento, che raggranellava informazioni dall’etere tramite un’antenna all’uso di Benjamin Franklin con l’aquilone.
Visto con gli occhi del ventunesimo secolo, ci pare una barzelletta mal congegnata; all’epoca, un turbinio di emozioni travalicavano la capacità di razionalizzare dinnanzi a una delle più avveniristiche invenzioni che l’uomo abbia mai partorito.
Se ne parlava da tempo, di questi “televisori”, oggetti di culto di uso abbastanza frequente negli Stati Uniti e in poche altre parti del Mondo. Un bel giorno, alla cara vecchia radio, il focolare domestico dell’inizio del Novecento, venne preferita la televisione .A questa enormità tecnologica, al tempo, si dette tale importanza da assoggettarla immediatamente a regime statale: la televisione nacque, fu, e permane in larga parte (che piaccia o meno), di proprietà governativa. Pubblica, insomma.
Per essere più precisi, tutto il comparto relativo alle radio tele comunicazioni, agli audiovisivi e al loro uso, furono subito regolamentati e messi a monopolio. Fu subito chiaro come fosse necessario fare altrettanto con tutto ciò che rappresentava la diffusione del segnale. Furono realizzati ponti radio, antenne immense e ripetitori funzionali alla capillarizzazione di un qualcosa che fu ben presto intuito, sarebbe stato di fondamentale importanza.
Ma importanza per chi? E soprattutto, a che prezzo?Facciamo un doveroso distinguo: la televisione italiana ha avuto una sorta di “golden age” laddove ha proposto alla cittadinanza un palinsesto di alto livello culturale. Ha insegnato agli italiani a leggere, a scrivere, a far di conto; ha portato in casa della gente comune il teatro e la lirica; ha dato accesso gratuito a straordinari luoghi esotici e monumenti storici tramite i documentari; ha rivoluzionato il costume attraverso gli sceneggiati, le sfilate, i grandi eventi mondani in diretta; ha costruito una scena musicale valida e finalmente popolare, portando alla ribalta la musica leggera e quella d’autore. Insomma, si può dire che per una ventina d’anni il sistema televisivo sia stato davvero rivoluzionario e davvero utile allo scopo di migliorare la vita delle persone.
Poi, un bel giorno, fu compreso il vero potenziale del nuovo media: la propaganda.Dagli USA fu mutuato – e abilmente trasformato in qualcosa di prettamente italico – il concetto per cui bombardare la cittadinanza attraverso messaggi più o meno sottintesi, fosse uno strumento di distrazione di massa dal potenziale suggestivo immenso. Dalle tribune politiche ai dibattiti – un metodo se vogliamo più diretto e parzialmente onesto – si passò al subliminale, ai sottotesti, alle intricate strategie che provenivano dal mondo della pubblicità.
E fu proprio questa, la pubblicità, a divenire il vero fenomeno massificato che gli operatori si aspettavano dalla televisione. Se il Carosello al giorno d’oggi viene considerato, a ragione, un geniale moto di creatività, è pur vero che diede il via a un concatenarsi di eventi di ben più becera natura. Il gusto per la raffinatezza lasciò il posto alla sistemica produzione in serie di spot e video sempre più brevi e di largo consumo, a braccetto con format ragionati appositamente per influenzare l’opinione pubblica.
Da quel momento anche l’iniziativa privata ebbe tutta l’intenzione di inserirsi nel mondo della televisione e con gli anni Ottanta del Novecento sorsero le prime, storiche, emittenti locali.La rivoluzione berlusconiana di trasformare la diffusione locale di televendite in un grande network nazionale definito puramente “commerciale” fu l’ultimo grande atto della storia della tv.
Cosa ci rimane oggi? Una liquefatta e flebile intenzione di far divulgazione, una sciatteria scomposta che viene consumata e digerita soltanto da un pubblico oramai vetusto, una lobotomizzante quantità di prodotti di fiction dalla trama esemplificata per la costante riduzione della soglia di attenzione… in sostanza un progressivo abbandono del media in favore – pare evidente – di nuove tecnologie di fruizione passiva più adatte (o forse no) ai nostri tempi.
Tanti auguri alla Tv e – parzialmente – grazie di essere esistita.
-
Determinanti sociali e salute mentale

“È importante che i Governi di tutto il mondo vedano la salute mentale come una componente fondamentale della salute pubblica”.
Margaret Chan, direttore dell’OMS dal 2007 al 2017.“Abbiamo bisogno di assicurare che a queste persone non venga negata la possibilità di contribuire alla vita sociale ed economica e che i loro diritti vengano tutelati”.
Benedetto Saraceno, Direttore del Dipartimento di salute mentale dell’OMS dal 1999 al 2010.Peccato che queste dichiarazioni risalgano al 2008.
E che da quella data le cose non siano cambiate o meglio: sono estremamente cambiate, ma in senso negativo. Difatti, ad oggi, l’Organizzazione Mondiale della Sanità si è riunita nuovamente per affrontare l’argomento sotto una nuova luce, quella relativa alle determinanti sociali, ambientali, economiche, lavorative, che in taluni casi – sempre più frequenti – possono divenire concausa ad alta sensibilità per lo sviluppo di patologie mentali.
Dopo l’esperienza della pandemia di Covid-19 il fatto si è ulteriormente acuito, portando la società ad una spaventosa involuzione sotto l’aspetto della salute psichica dell’uomo.
Diviene dunque di primaria importanza, per le alte sfere della sanità pubblica, prendere in considerazione i fattori esterni che possono minare alla stabilità mentale della popolazione globale e considerare quali siano le misure opportune da assumere nell’ottica di migliorare gradualmente la qualità della vita in ambito relazionale e umano.
La realtà dei fatti è avvilente e senza dubbio preoccupante: la mancanza di serenità è la prima questione che emerge se guardiamo alla società odierna: mancanza di diritti civili, alla casa, alla dignità personale; carenza di lavoro e di risorse; peggioramento dell’istruzione, deterioramento delle strutture pubbliche, malasanità. E potremmo continuare all’infinito nello snocciolare quali lacune – sarebbe meglio dire baratri – sussistano nel tessuto pubblico, dimodoché al cittadino manchino certezze e dunque venga meno quel senso di sicurezza che dovrebbe essere garantito in una società sviluppata e conforme alle basi illuministe a cui si ispira ogni costituzione democratica.Basta partire proprio dal comparto sanitario per denotare le immense criticità che minano la salute mentale delle persone: in un qualsiasi ospedale la malattia psichiatrica è considerata come minore se non peggio, come fattore discriminante per la credibilità del paziente. Un paziente che diviene oggetto nelle mani del personale medico e infermieristico, e che deve fare i conti con la “lotteria” di chi gli capita a tiro: può trovarsi davanti un animo sensibile e umano, di grande professionalità, che arriverà a comprendere le sue necessità di natura psicologica e psichiatrica oppure potrà finire sotto la tutela di “professionisti” che non possiedono alcuna empatia e che non conoscono affatto il corretto modo di porsi nei confronti di tali questioni.
Questo perché? Perché manca una formazione specifica e latitano protocolli adatti alla tutela della salute mentale all’interno dei reparti di cura.
Ancora più a monte, manca una cruciale sensibilità nei quadri dirigenziali, che non solo ignorano ma addirittura nascondono, omettono, rifiutano che il punto primario di partenza di un qualsiasi ospedale è e deve essere il benessere psicologico dei pazienti.
Dunque non esiste preparazione come non esiste educazione al rapporto umano e se queste fondamenta mancano nella sanità – luogo dove le norme di igiene mentale dovrebbero essere redatte – è facile immaginare a che livello preistorico siano fermi tutti gli altri organi pubblici in termini di relazioni sociali.
Dalle scuole alle residenze per anziani, dalle amministrazioni ai centri per l’impiego, dalla viabilità pubblica ai tribunali, dagli uffici postali fino alla previdenza sociale, ognuno di questi luoghi favorisce – più o meno indirettamente – l’insorgere di problematiche e patologie mentali, siano esse già preesistenti o meno nel cittadino sottoposto a stress.Ma non perdiamo di vista l’obiettivo primario di questo approfondimento, vale a dire il prendere in esame ciò che dovrebbe contribuire al benessere mentale e non l’opposto. Perché è questo il punto centrale: la salute mentale riguarda tutti , anche chi è attualmente sano, che se sottoposto a stress di origini esterne, può divenire esposto al rischio di patologie psichiatriche.
Nella società attuale, in cui viene acuito il senso di isolamento, sussistono dei paradigmi che divengono causa di malessere a qualsiasi livello culturale, di sviluppo e di progresso; anzi, potremmo dire che laddove il progresso è maggiore, maggiori sono gli indicatori di stress.
Il mondo occidentale è troppo veloce per una mente normale e questo causa un deficit di attenzione che porta l’individuo in uno stato di sofferenza e di distrazione perenne. La distrazione ha come conseguenza estrema l’alienazione. Tale alienazione diviene critica quando il metodo sociale in cui viviamo porta a livelli esasperanti l’agonismo e l’antagonismo, in una sorta di individualismo deformato e spogliato del suo significato originario.
Le dinamiche relazionali sono dettate da un egotismo (una percezione di sé proiettata verso l’interno e non verso il prossimo) che nel 2023 ha raggiunto livelli inauditi: le persone pensano, parlano, comunicano, senza l’intento di porsi in correlazione con i suoi simili.
Gli standard a cui i media ci sottopongono sono modelli irraggiungibili composti da una perfezione che – non essendo umana – genera soltanto frustrazione.
Se a tutti questi aspetti ontologici andiamo a sommare le devianze oggettive, quali le lacune esposte precedentemente e le difficoltà collettive più comuni quali la mancanza di stimoli, la solitudine, l’emarginazione, la crisi identitaria, ecc. , il risultato è drammatico.
Ecco che i fattori “esterni” di cui parlavamo in apertura divengono quei determinanti sociali a cui nessuna mente è capace di resistere.Allora quali sono i fattori che dovrebbero contribuire alla sanità mentale, qualora volessimo stilare un principio di base in cui essa venga preservata come primario diritto inalienabile dell’uomo?
Non è semplice ma possiamo provarci.
Primo, il diritto alla diversità di apprendimento e di approccio. Una società sana di mente non pretende da tutti lo stesso ritmo e gli stessi metodi, piuttosto si impegna affinché ognuno riesca nei suoi intenti e nelle sue previsioni attraverso i suoi tempi, che sono mutevoli e soggettivi.
Secondo, è necessario vivere in un’armonia solidale laddove la collaborazione e la cooperazione siano anzitutto empatiche e spontanee e non frutto di accordi o corporativismi; ognuno dovrebbe avere il diritto di chiedere aiuto senza vergogna, senza timori, senza che venga per questo discriminato, perché ciascuno di noi ha un lato debole per il quale bisogna fare ricorso al prossimo, in ottemperanza al concetto antropologico fondamentale per cui siamo nati animali sociali.
Inoltre, è basilare che uno stato si adoperi nel mantenere viva l’iniziativa personale senza però abbandonare a se stesso coloro i quali possano avere uno svantaggio in tal senso. Se appunto nessuno di noi è uguale all’altro e tutti noi abbiamo punti di forza, è pur vero il contrario, vale a dire che ognuno di noi possiede fragilità. Tali fragilità – per non diventare critiche – devono essere contenute e sostenute, affinché i diritti fondamentali vengano rispettati.Ora, ciò che abbiamo detto non sono altro che belle parole, principi piuttosto ovvi che non hanno alcuna funzione se non vengono applicati in maniera metodica e soprattutto endemica. Il mondo dovrebbe dunque cambiare? Certo che sì, ma soltanto nel dichiararlo comprendiamo che si tratta di un’utopia.
Una semplice, forse banale, soluzione potrebbe risiedere nel recuperare il valore della lentezza. Il tempo è una discrimine ad elevata sensibilità nel comparto della salute mentale, e ogni cronometraggio imposto aumenta il rischio di perdere di vista il bisogno atavico di serenità di cui l’uomo sta perdendo ogni traccia.
In copertina : Psiche apre la scatola d’oro – J.M. Waterhouse, 1903
-
Intelligenza Artificiale e mestieri dell’arte: una conversazione con Fabiano Ambu

L’avvento delle intelligenze artificiali rappresenta oggi una realtà sempre più concreta. Non più un concetto in divenire ma tangibile oggetto da definire attraverso uno studio approfondito delle implicazioni sociali e professionali che essa può causare. L’AI è una tecnologia che può inserirsi in qualsiasi contesto lavorativo e che intacca – sia come astrazione che come impiego effettivo – il progresso. E’ necessario dunque comprendere a fondo se questo intervento virtuale possa beneficiare o nuocere al progresso stesso. Come blog imparziale e votato alla libertà di espressione mediante la ricerca e l’approfondimento, abbiamo cercato personalità autorevoli che potessero darci pareri in merito, siano essi positivi che negativi. Al momento, i professionisti “a favore” non ci hanno ancora risposto; la nostra porta rimane aperta a chi volesse farsi avanti spiegando e argomentando la propria posizione.
Di seguito, abbiamo invece avuto il privilegio di ospitare sulle nostre pagine l’opinione di Fabiano Ambu: fumettista, illustratore e docente di fama internazionale, al quale abbiamo posto delle domande alle quali gentilmente ha risposto con chiarezza e grande professionalità. La sua visione per quanto concerne l’inserimento delle intelligenze artificiali all’interno del mondo del lavoro – nella fattispecie nei mestieri dell’arte – è decisamente negativa, ponendo massima attenzione agli aspetti culturali e sociali che potrebbero degenerare in una escalation senza precedenti a livello storico e antropologico.
Vediamo nel dettaglio che cosa Fabiano Ambu ci ha detto, cogliendo l’occasione per ringraziarlo con stima e calore.Iyoko: Chi è Fabiano Ambu e perché combatte ogni giorno l’uso dell’intelligenza artificiale, fattispecie nel contesto artistico? Quali sono le motivazioni che la spingono ogni giorno a mettersi in prima linea per sensibilizzare verso gli oggettivi pericoli di questa nuova tecnologia, vera e propria “massacratrice di talento” e professionalità?
Fabiano Ambu: Fabiano Ambu è, prima di tutto, un essere umano consapevole di vivere all’interno di un sistema che deve migliorare e che crede nella possibilità di realizzare una società migliore di quella che sta vivendo. Sono anche un professionista che ha dei valori profondamente etici e crede nell’importanza della crescita individuale e del merito come somma di capacità, impegno e dedizione. Inoltre faccio dei corsi per insegnare il mio mestiere e ho un quadro chiaro sulle problematiche di un sistema dove si professa il successo a tutti i costi senza concentrarsi sul percorso per ottenerlo.
Prendo posizioni che ritengo necessarie, come nel caso della regolamentazione delle AI in un’ottica che prevede uno sguardo verso il domani non solo verso i miei interessi personali. Ho una forte coscienza civica che mi porta sempre a ragionare in modo sociale non solo individuale e prendere posizioni verso le parti più fragili di questa società, lo faccio per quanto mi è possibile, anche attraverso il mio lavoro.
La mia posizione rispetto alle Ai non è legata a una sorta di paura verso le novità tecnologiche e sociali, purtroppo è una critica che ci si sente fare spesso quando si affronta il tema delle nuove tecnologie, soprattutto quando si affronta la discussione con fanatismi e interessi individuali, in realtà tutti gli artisti che stanno prendendo posizione contraria a questo utilizzo deregolamentato del sistema Ai sono professionisti in continua sperimentazione, che usano gli strumenti più moderni e aggiornati per lavorare.
Ci sono due problemi fondamentali in questo indiscriminato utilizzo delle AI, il primo è di carattere professionale, c’è una palese violazione di diritti d’autore ottenuto con estrema disonestà, scorrettezza e illegalità (si stanno discutendo le questioni burocratiche mentre scrivo), secondo è quello etico, un sistema creato per sostituire la mente umana nelle professioni che richiedono creatività e ingegno. Quello delle AI è un sistema profondamente sbagliato.
Iyoko: L’avvento dell’intelligenza artificiale sembra principalmente colpire il settore creativo. Tale deriva è causata dalla sproporzionata mole di contenuti offerti, sempre più brevi e veloci, privi di una qualsiasi giustificazione artistica. È una questione di pigrizia da parte di chi crea o di ignoranza da parte di chi fruisce? O entrambe?
Fabiano Ambu: I motivi per cui si propone l’AI in ambito creativo è per una questione puramente economica, massimo profitto con minimo sforzo anche a costo di distruggere il sistema e ferirlo nel profondo.
Viviamo in una società pigra e superficiale con dei problemi dati dalla pessima gestione e regolamentazione dei social che ha creato delle dinamiche fuorvianti di realizzazione personale e successo legate al potere economico più che alla crescita emotiva e culturale. Siamo tutti consapevoli di questi danni ma troppo codardi e pigri per affrontarli, viviamo della speranza che i problemi si risolvano da soli.
Adesso ci troviamo di fronte a nuove e più pericolose derive date da questo sistema AI, lo definisco tale e non strumento, perché è evidente che si sta instaurando un nuovo sistema sociale ancora più classista del precedente, che minerà la capacità degli individui di porsi criticamente di fronte ai problemi.
La proposta di una omologazione estetica data dalle AI educherà la massa verso l’incapacità di comprendere le novità e il progresso estetico.
Le Ai propongono dei modelli che sono rivisitazioni di canoni e stili già assimilati dalla società e quindi di facile comprensione, lo fanno in una società ormai strutturata con l’unico scopo di accumulare ricchezza senza interessarsi al reale progresso sociale.
Viviamo in un sistema di consumismo ossessivo compulsivo, che calpesta ogni forma di empatia e senso civico, dando la sensazione che la vita sia solo un esperienza di accumulazione seriale di cose, per poi scoprire che il nostro cammino ha una fine e che il percorso è la parte essenziale della nostra esistenza.
Purtroppo l’ignoranza è alla base di ogni forma di schiavitù, il calo di lettori e l’incapacità di reagire criticamente sta minando la nostra stessa evoluzione.
Iyoko: La mancanza di senso critico e di senso estetico dilaga. Ciò favorisce l’avvento dell’intelligenza artificiale che offre contenuti (testi e immagini principalmente) costruiti con superficialità e di dubbia qualità. Eppure, molte persone sembra che si “accontentino” di ciò che gli viene proposto. Sovraccaricare la mente del fruitore medio allontana la percezione estetica della bellezza?
Fabiano Ambu: Per questo motivo parlo spesso di pigrizia, si è troppo intenti a osservare l’obbiettivo ma lo si vuole raggiungere senza faticare, senza studio e senza sacrifici, come se tutto fosse dovuto. Chi ha ottenuto dei traguardi attraverso un percorso è consapevole che senza di questo non si è ottenuto un reale successo, i traguardi sono
indispensabili per sentirci vivi e se non richiedono sforzi il risultato è inutile se non fallimentare per il proprio io.
Non faccio colpe agli individui ma al sistema, perché è il sistema che deve essere strutturato per educare e far crescere la società.E’ palese che una crescita culturale porta al progresso, a nuovi traguardi dell’essere umano, se leviamo possibilità di creare e di vivere della propria creatività stiamo minando le basi per il progresso e senza di questo c’è solo involuzione se non la fine del concetto di società civile.L’Arte spesso si da per scontata, ognuno la definisce in modo soggettivo, ma in realtà è la risultante di una continua evoluzione che può essere compresa solo se studiata, richiede conoscenza e sensibilità per comprendere quanta libertà e quale importanza abbia nella creazione del futuro.Un altro fenomeno che mi ha colpito in merito al tema AI è quello di coloro che osteggiano e si scagliano contro le legittime manifestazioni di dissenso degli artisti. C’è quasi una perversa gioia nell’agognare la sostituzione degli artisti e delle professioni legate all’arte con le AI, come se di fronte a uno sciopero, in cui si rischia il licenziamento di milioni di operai, si facesse il tifo per l’Azienda che licenzia indiscriminatamente, distruggendo famiglie e vite.
Questo è uno degli aspetti che più mi disturba e che mi mette in allarme sull’avvento delle AI, c’è una volontà di distruggere la parte pensante e critica della società, da parte di chi è consapevole, ma anche di queste persone che prive di capacità, pazienza, voglia o motivazione preferiscono portare tutti a fondo pur di non ammettere di essere loro il problema per se stessi, una frustrazione che purtroppo ricadrà su tutti.
Iyoko: Il futuro è per forza automatizzazione? Bisogna sempre ricercare nel progresso comodità e velocità? O sarebbe invece necessario ricercare un nuovo spazio dedito alla lentezza della creazione? Quanto conta il fattore TEMPO nel lavoro e nel processo creativo?
Fabiano Ambu: Il futuro e il progresso sono concetti differenti. Il futuro è qualcosa che ci aspetta e che occorre costruire, è determinato da scelte e dal caso. Il progresso invece dipende esclusivamente da come vogliamo costruire il futuro, la comodità, la velocità, l’automazione non sono per forza parte del progresso.
Spesso si confonde la tecnologia con il progresso, ma la prima non è detto che sia un passaggio che porti verso a dei passi avanti, a volte può determinare un freno al progresso.
La tecnologia, la scienza sono strumenti che servono per costruire il progresso, come lo sono la filosofia, la letteratura e le arti. Cito una definizione sul progresso che riporto al volo dal web: “L’acquisizione da parte dell’umanità di forme di vita migliori e più complesse, spec. in quanto associate all’ampliamento del sapere, delle libertà politiche e civili, del benessere economico e delle conoscenze tecniche”. Spesso mi sento accusare che le mie critiche verso le AI sono dovute alla mia incapacità di comprendere il progresso e volerlo arrestare, invece la mia opposizione e richiesta di regolamentazione è proprio in funzione del progresso UMANO.
Iyoko: In Italia viene ostentato con onore “campanilistico” il valore dell’artigianato, in controtendenza netta rispetto all’intelligenza artificiale. Questa pubblicità al made in Italy e al ritorno al concetto di “bottega” è solo moda per reel e video suggestivi da caricare sui social, oppure c’è qualche barlume di speranza?
Fabiano Ambu: L’Italia è un Paese sulla soglia dell’autogestione, non si riescono a creare dinamiche collaborative e tutti i successi sono dovuti a individui illuminati che si impongono (negativamente o positivamente) mantenendo, seppur con i dovuti limiti, viva e vivace questa Nazione.
Viviamo ormai di rendita dei successi passati, moda, design, arte ma in realtà siamo solo dei imbonitori da fiera, degli ottimi venditori di pentole che ripropongono sistemi e prodotti già rodati, rischiamo e sperimentiamo troppo poco e premiamo la mediocrità più del merito, questo in ogni settore.
L’artigianato va sostenuto con le azioni non con gli spot, mi pare evidente che cultura e saper fare sono all’ultimo posto degli interessi del Paese, sia politici che economici.
I social sono la finestra su questo sistema devoto all’apparenza che purtroppo non riesce a produrre talenti o idee se non riproposte e confezionate in un continuo loop culture.
Sul campanilismo italiano stenderei un velo pietoso, siamo solo dei tifosi che non riescono a esser critici nemmeno per tutelare i propri interessi.
Per rimanere sul tema AI, in questo tipo di società una tecnologia come questa creerà dei danni inqualificabili, anzi li sta già creando.
Iyoko: Veniamo al settore di riferimento: il fumetto. Quali sono i rischi autentici e realistici per illustratori e sceneggiatori, con l’avvento e l’abuso dell’intelligenza artificiale?
Fabiano Ambu: I rischi si sono palesati poco dopo l’esposizione mediatica delle AI, io vivo a Milano e parecchie Agenzie e professionisti nell’ambito della comunicazione usano le Ai con l’obbiettivo di tagliare i costi degli illustratori e i tempi di lavoro (pigrizia unita a bassi compensi).
Giusto per correttezza ci tengo a dire che il tenore di vita di illustratori, fumettisti e artisti in generale rasenta la soglia della povertà se non starci dentro completamente. A parte alcuni fortunati casi, gli autori percepiscono a malapena uno stipendio medio, con la sola differenza che non hanno continuità lavorativa.
Per avere un quadro generale del problema AI occorre capire la situazione di queste categorie, precedentemente a questo avvento tecnologico. Fumettisti, illustratori e sceneggiatori erano già categorie non tutelate e che non hanno alcun ammortizzatore sociale, vivono perlopiù sui diritti di utilizzo e spesso non ricevono royalties adeguate che permettano loro una dignitosa rendita. I compensi per gli autori sono solitamente retribuiti in tempi lunghi, spesso si rischia di non esser pagati e non è garantita continuità, una libera professione ma che mantiene dei compensi da stipendio minimo. In questo contesto intervengono le AI che permettono di tagliare i “costi” di questa categoria che vive in una totale assenza di diritti e tutele.
Le AI in questo momento stanno SOSTITUENDO i creativi e gli artisti in buona parte delle mansioni che gli permettevano di sostentarsi e produrre opere su cui sperimentare e fare ricerca. Il mestiere dell’Artista richiede un continuo studio e ricerca per trovare nuove strade e proporre innovazioni estetiche, che storicamente hanno guidato il progresso dell’intera società.
Quando vedo dire o scrivere, con estrema leggerezza e superficialità, che l’arte non morirà mai perché chi fa arte lo farà a prescindere dalle AI, comprendo quanto si banalizzi l’importanza dell’Arte per il progresso di una società. Storicamente l’Arte ha sempre avuto bisogno di essere supportata economicamente, gli artisti sono lavoratori, professionisti che per vivere hanno bisogno di sostentarsi. La visione bucolica di Arte che vive nell’etere, fatta di ispirazione e agiatezza non è reale ed è data da una profonda ignoranza e superficialità. L’Arte vive se viene sostenuta economicamente e senza Arte siamo solo dei primati senza futuro.
Siamo di fronte alla volontà di sostituire le menti, la creatività e tutto quello che ci rende esseri intelligenti, con delle macchine che ingurgitano e vomitano le più grandi innovazioni e geniali risorse intellettuali che la storia ci ha dato, nel mio ambito per creare meme e immagini pop accattivanti e senza senso, nella più becera forma estetica che un essere parzialmente senziente possa partorire attraverso casuali pensieri banali e stupidi.
Le Ai sono una tecnologia con grandi potenzialità che potrebbero realmente accompagnarci verso un reale progresso sociale, ma l’utilizzo che se ne fa è solo di tipo economico e questo porta tutti quegli elementi pigri e arrivisti a sfruttarla per acquisire delle posizioni più alte in un sistema che non propone una crescita qualitativa.
Se è quasi concepibile che chi non sa fare e non capisce possa aspirare a una professione senza preparazione e consapevolezza, è inaccettabile che i professionisti possano non comprendere le criticità di un futuro in cui la creatività e l’Arte possa vivere di una continua replica del già esistente e dove gli artisti sono regalati a meri esecutori, se non esclusivamente correttori al servizio delle macchine.Se le AI stanno ottenendo tanta attenzione è perché viviamo in un periodo storico dove non abbiamo degli anticorpi critici e dove l’individualismo diventa il motore per raggiungere un facile successo economico.
Per quanto mi riguarda siamo di fronte a un problema che sarà fautore di un’enorme crisi di sistema che minerà la cultura e la civiltà fino alle fondamenta, la mia speranza è che ci sia un risveglio delle menti illuminate che finalmente si attivino nella realizzazione di un vero progresso, levando dalle mani di questa idiocrazia il destino delle future generazioni. -
[cherofobia]
![[cherofobia]](https://iyokoblog.files.wordpress.com/2023/07/cherofobia.jpg?w=1024)
Una deformità inconcepibile – per citare Hannibal Lecter – colpisce l’abuso dei social network nella misura in cui si presenta al pubblico la propria vita privata. Tale stortura è rappresentata dalla sovraesposizione di sé, atto per altro sempre più in crescita tra gli adulti e i cosiddetti “boomer”, fino al punto di trasfigurare la realtà caricata online e confonderla con l’esistenza reale. Ciò induce le persone autrici di tale illusione a convincersi che sia quantomeno necessario – in primis – essere sempre attivi, sempre in giro, sempre coinvolti, sempre presenti: in breve, sempre felici.
Attenzione perché questo risvolto di ostentazione, sebbene avvilente, non è certo l’unico mezzo che si utilizza per apparire tanto quasi da essere, seppur non essendoci per niente.
Questo per dire che non si debba giungere a demonizzare senza ragione uno strumento dalle potenzialità positive e costruttive come un social network e ritenerlo colpevole o concausa di un atteggiamento volto a voler sembrare ciò che non si è: l’estetica e la melodrammatica arte dell’apparenza esistono da tempo immemore, finché nella memoria si trovi traccia scritta del teatro e delle maschere. Quindi, senza voler fare luddismo a ogni costo, consideriamo come sempre l’abuso di uno strumento una semplice e sola responsabilità di chi lo fa e niente di più.
Ma se vi dicessimo che esiste anche l’esatto contrario di questa tendenza a mascherare la propria tristezza col sorriso di Pulcinella?
Se vi confessiamo che da anni ormai la psichiatria, la psicologia, la sociologia, la pedagogia, insomma una moltitudine di accademici affronta l’atavico ossimoro dell’apparenza? La sfida che soggiace nell’animo dell’insicuro?
Stiamo parlando della paura di essere felici .Giulio Cesare Giacobbe, psicologo di raro acume, intitolava così un proprio manualetto satirico e intelligente: Come smettere di farsi le seghe mentali e godersi la vita.
Nel caso specifico in oggetto, andiamo letteralmente oltre: “se appena mi distraggo un attimo e mi permetto di essere spensierato – di allentare la presa, per così dire – le più abissali divinità antiche si ardimentano in un complotto ai miei danni atto a distruggermi, mettendomi in mano ai flutti tempestosi di un fato ignobile e beffardo?”
Capiamoci, è forse la più grande insicurezza del millennio, di un ventunesimo secolo che è giunto senza chiedere permesso e ha sbaragliato l’essenza stessa dei concetti di stabilità e serenità, facendoci dimenticare definitivamente cosa possano voler dire quei due sostantivi che ogni giorno ricerchiamo in modo esasperato; un po’ come tendiamo a fare con la noia, quando diventiamo pericolosamente adulti e ci rendiamo conto che il tempo rimasto è tremendamente poco.Vorremmo essere felici ma temiamo le conseguenze di ciò, di questa imperdonabile disattenzione: non ci vogliamo più concedere la leggerezza.
E non è un caso se il termine qualche annetto fa diventò addirittura il titolo per una canzone di breve successo qui in Italia: Cherofobia , di tale Martina Attili .
Cherofobia deriva dal greco “kairos” – che rallegra – e “fobos” – paura. Si tratta di un disturbo non ancora inserito tra le patologie, dunque facente parte delle cosiddette parafilie e significa letteralmente “avere paura e avversione per la felicità”; fobia causata dalle possibili conseguenze nefaste che potrebbero accadere se ci distraiamo o ci permettiamo la gioia di godersi il momento. Non si tratta di scrupolosità, di paranoia, di metodo compulsivo, ma proprio di paura; una sorta di step successivo ad un’eccessiva forma di pessimismo.
Come già sostenne Emil Cioran, che definì l’intera esistenza una “colpa da scontare”, risulta evidente quanto già da secoli si intenda la vita quasi al pari di un lento e doloroso processo di espiazione, il quale si intensifica relativamente al periodo storico che si vive; un contesto di diffusa debolezza intellettuale, di insicurezza, di precarietà, rendono le persone vittime di loro stesse, di fronte a un innaturale fenomeno di autoflagellazione dove si va a ricercare la grande responsabilità del fallimento all’interno della propria sfera emotiva o mentale.
Ed ecco che roviniamo tutto.
Con la paura della felicità ci giochiamo occasioni uniche che un pervasivo senso di vacuità altrimenti ci lascerebbe godere; mandiamo in frantumi l’istinto, la naturalezza, la giustificata frivolezza dei momenti conviviali.
Non arriviamo al punto di soddisfare alcuna nostra esigenza volitiva perché tutto ciò che galleggia nella bolla della tranquillità ci è precluso, senza appello.Da chi? Dal peggior censore che possiamo incontrare: noi stessi.
Solo noi sappiamo quanto “gli antichi dei greci potevano essere invidiosi della felicità umana”, per usare le parole di Schopenhauer, un altro filosofo che la vita proprio non riusciva a godersela.
E pensare che già durante l’epoca Ellenica c’era chi cercava di diffondere ottimismo in quel clima disturbato e infelice: Epicuro – filosofo fondatore dell’omonima corrente detta “epicureismo” – si dichiarava fortemente avverso alla teoria per cui talune forze maggiori potessero influenzare la vita degli uomini i quali invece hanno tutto il diritto di arrogarsi la ricerca della felicità addirittura come fine ultimo della loro esistenza.
Un obiettivo che poi sarebbe stato ripreso di gran voga dagli umanisti e dagli illuministi, in due epoche di rinascita storica famose proprio per aver restituito dignità all’uomo e alla sua autodeterminazione, libertà e lecita persecuzione dei propri sogni.
Quello che allora oggi ci domandiamo è: dov’è finito l’epicureismo spicciolo che giù per le strade delle città si chiama “spirito di autoconservazione”?
Dov’è finita la voglia di non pensare troppo al domani e alle conseguenze di ciò che facciamo? Di prendersi la briga di rischiare?
Tuffiamoci dalla scogliera, forse la risposta è là in fondo in mezzo al mare. -
Volontariato: una responsabilità (?) civile

Che si tratti di caso o di fortuna non importa, il fatto stesso di essere più o meno casualmente finito a occuparmi di terzo settore e volontariato per un periodo significativamente lungo da farmi comprendere diverse sfaccettature umane e pratiche di tale impegno, può e deve essere considerato dal sottoscritto una vera e propria benedizione.
Per essere esatti, lo definirei un privilegio che la vita – con le sue innumerevoli deviazioni – mi ha riservato.
Altrettanto privilegiata è la posizione di cui ho potuto fare tesoro all’interno di una variegata e stimabile umanità, in qualità di testimone diretto delle imprese che tale universo compie ogni giorno al fine di generare un bene comune inteso come supporto reale al prossimo, senza vincoli, lucro o obbligo alcuno.
Ciò che ho potuto comprendere come prima istanza nella mia avventura di reporter del Terzo Settore è che purtroppo – e sottolineo purtroppo in quanto di grave fatto si tratta – il volontariato tendenzialmente è diventato il sistematico approccio alla necessità e al bisogno laddove lo Stato, gli enti e le istituzioni risultano vacanti.
Un dato sensibile che sottolinea la drammatica questione in termini di abbandono del cittadino da parte delle autorità pubbliche è il seguente: il volontariato, in Italia, lo diamo per scontato.Diamo per scontato il fatto che un’ambulanza ci venga a prendere se c’è urgenza, che gli anziani abbiano compagnia e supporto, che i senzatetto trovino ristoro e un riparo per la notte, che i bambini possano svolgere attività sportive, che le persone affette da disturbi psichiatrici trovino conforto e personale competente, che gli ammalati cronici vengano accompagnati a seguire terapie fondamentali, che le medicine siano consegnate agli indigenti, che i richiedenti asilo vengano introdotti in maniera costruttiva nel mondo del lavoro, che gli studiosi trovino ancora libri su cui poter affinare ricerche, che durante un incendio ci sia un attivo supporto ai vigili del fuoco, che alle vittime di alluvioni venga prestato immediato soccorso, che dopo la devastazione di un terremoto ci siano persone e cani addestrati in grado di toglierci da sotto le macerie, che la conservazione di siti storici, monumentali e archeologici sia garantita nel tempo con o senza fondi pecuniari, che i ragazzi con disabilità fisiche o mentali siano inseriti senza traumi all’interno della società, che gli stessi individui portatori di handicap possano accedere ai servizi di base tramite l’abbattimento di barriere architettoniche, che a coloro che sono affetti dalla sindrome di Down vengano offerte attività atte all’inclusione, che l’ambiente marittimo e costiero venga preservato rispettando il suo fragile equilibrio, che gli animali vengano tutelati e sia possibile concedergli gli stessi diritti degli uomini, che a coloro che hanno fame venga distribuito cibo e acqua, che alle minoranze – qualsiasi esse siano – sia data voce e risonanza in merito alla rivendicazione dei propri diritti, e così via, potremmo andare avanti per pagine e pagine elencando ciò che il sistema nazionale di associazioni proponga ed eroghi grazie al solo e unico contributo volontario delle persone, atto alla cooperazione spontanea tra umani.
Questo si chiama collaborazione. Un corporativismo nato dalla necessità di sopperire alla latitanza o incapacità o effettiva impossibilità di un apparato pubblico non sempre in grado di poter canalizzare risorse verso la cittadinanza.
E quando diamo per scontato tutto questo ci dimentichiamo quasi sempre di capire da dove arriva l’aiuto per il quale abbiamo teso la mano; pensiamo inconsciamente che sia una cosa pubblica , un ritorno di ciò che abbiamo devoluto in tasse e contributi, un’effettiva conferma che la macchina funzioni; in realtà è soltanto frutto di altre persone fatte proprio come noi, con i nostri stessi problemi e le nostre stesse capacità, le quali però hanno deciso di mettersi a disposizione della comunità per fare comunità.Il risultato di questo spirito umano di empatia è quello di costituire dunque realtà attive e proattive che vanno dritte al punto, pronte alla soddisfazione immediata di un bisogno, senza ricevere niente in cambio per questo servizio. Un mutuo soccorso che garantisca diritti, dignità e autodeterminazione alla ricerca di una felicità collettiva sempre più distante e complessa.
In parole brevi e del tutto incapaci di poter descrivere appieno il senso di vita che permea la quotidiana attività del mondo del volontariato, questo piccolo miracolo dal basso è ciò che più mi ha colpito nel periodo in cui ho potuto vivere e raccontare il mondo del terzo settore.
Oggi è necessaria una riflessione che ponga la massima attenzione al senso di urgenza che è generato dalla profonda disparità sociale che dilaga nel nostro Paese. Ci sono carenze strutturali e infrastrutturali, umanistiche e sociosanitarie immense che definiscono autentici pericoli. Anche in questo caso le caratteristiche che descrivono il volto di una crisi identitaria globale sarebbero innumerevoli e per ognuna di esse esiste – e qui torniamo alla fortuna – un’associazione di riferimento che va a operare un difficilissimo lavoro laddove le questioni divengono più delicate.
Ma questa fortuna non può durare per sempre. C’è dunque bisogno di rivoluzionare completamente la nostra stessa percezione del volontariato; umana coscienza che si eleva e crea presupposti per la civiltà solo se è reciproco, transitivo e solidale. -
Breve storia del manifesto

L’origine della parola “manifesto” è da ricercarsi nelle più remote pieghe della storia, in quanto il termine ci dona la spiegazione stessa della funzione di tale oggetto: manifestare, portare a conoscenza, rendere noto.
Tralasciando i secoli in cui tale esposizione di una qualsiasi attività veniva operata in modo rudimentale, attraverso i graffiti o per voce dei proclami di un banditore, arriviamo al XV Secolo quando l’invenzione della stampa a opera di Gutenberg offrì la possibilità di realizzare più copie identiche di uno stesso testo in modo da poterle diffondere ovunque con grande semplicità. Se la produzione di libri emancipò la cultura rendendola accessibile a quella che fino ad allora era considerata una vastità irraggiungibile, la stessa possibilità in termini pubblicistici rese un enorme contributo alla nascita di un’embrionale industria pubblicitaria.
Manifesti recanti leggi e regolamenti, affissioni che citavano le ultime notizie, reclami di fiere e mercati imminenti, locandine di spettacoli teatrali o circensi iniziarono a venire disseminati in giro per le città e le campagne del mondo.Il manifesto ottiene la sua attuale dimensione nell’Ottocento in Francia, quando diviene definitivamente utilizzato come strumento di comunicazione commerciale e politica. In questo periodo si scopre anche la potenzialità artistica dell’immagine pubblicitaria, tale da donare una nuova dignità al manifesto stesso: nasce la “golden age” della rappresentazione grafica e dell’illustrazione.
Celebri rimangono i lavori compiuti dai due più rappresentativi autori di opere da affissione: Henri de Tolouse-Lautrec e Jules Cheret. Pittori dallo straordinario talento comunicativo, i due artisti si differenziano dalla comunità intellettuale parigina arrivando per primi a spremere il loro mestiere in funzione di un mero atto pecuniario: il lavoro su commissione per eventi mondani, fiere, mostre e quant’altro la grande capitale in fermento proponeva al pubblico.
L’inizio del Novecento coincide con l’imposizione culturale dell’arte Liberty, conosciuta in Francia come Art Nouveau e “Modernismo” in Italia. In tale contesto lo sviluppo del manifesto è proporzionale all’enorme ondata di correnti creative che si sviluppano nelle principale scene europee, asiatiche e americane. Si diffonde una certa mania per il Giappone che andrà a influire su innumerevoli produzioni illustrative, scultoree e architettoniche. Il manifesto, conoscendo un incremento tecnico di notevole portata, diviene simbolo di modernità e velocità di comunicazione, media perfetto per le avanguardie che prosperano in seno al Liberty: è il caso di segnalare principalmente il Futurismo in Italia e il Dadaismo in Francia. Gli artisti che rappresentavano l’interezza del pensiero di tali correnti trovarono nell’ “affiche” un alleato e un supporto straordinario; sono infatti notorie le incursioni di pittori, poeti, scultori e architetti nel mondo della pubblicità laddove porre attenzione all’impatto ultradinamico della comunicazione contemporanea.
I nomi più rappresentativi tra cui andare a ricercare queste magnifiche opere d’avanguardia sono certamente Marcel Duchamp, Alphonse Mucha e il leggendario Raymond Savignac, ideatore per quarant’anni di campagne pubblicitarie entrate di diritto nel mito del Ventesimo Secolo . Per quanto concerne l’Italia, gli autori futuristi di maggior successo sono stati certamente Leonetto Cappiello – creativo e pubblicitario – e Fortunato Depero – pittore prestato alla cartellonistica di cui ricordiamo certamente le strepitose pubblicità per Campari e Martini.Prima dello scoppio della Seconda Guerra Mondiale, la pubblicità cartacea ebbe un altro vivace momento di progresso che coincise con l’avvento dell’Art Déco. Nato in Francia ma affermato negli USA, è proprio dall’America che giungono i lavori più importanti del periodo, in cui per altro iniziano a fiorire – a New York per le aziende e a Los Angeles per i film – le prime grandi agenzie pubblicitarie che firmeranno manifesti di assoluto valore storico, artistico e comunicativo. Tornando in Europa, l’Art Déco conosce due divagazioni sul tema che doneranno alla grafica pubblicitaria un grande contributo: stiamo parlando di due accademie, una tedesca e una austriaca, chiamate Bauhaus e Jugendstil. Lo Jugendstil (stile giovanile, fresco) viennese propose innovazioni tecnologiche impressionanti realizzando le prime forme astratte e geometriche di comunicazione pubblicitaria. La scuola Bauhaus, pur condividendo con gli austriaci il medesimo rigore, introdusse l’inserimento di concetti e messaggi sociali e razionali, alla ricerca di sottotesti culturalmente più elevati.
Sebbene la totalità dell’economia mondiale e del progresso artistico subirono un arresto di immane portata, il manifesto seppe rinnovarsi e rimanere in piedi anche durante la Seconda Guerra Mondiale. Le nazioni coinvolte nel conflitto abbisognavano con urgenza di una comunicazione efficace che facesse leva sulla speranza e le motivazioni di popoli atterriti e in grave pericolo; andare alla ricerca di motivazioni, di granitiche convinzioni: è l’alba del manifesto di propaganda politica.
Una tipologia di comunicazione che da quel momento in poi avrebbe per sempre accompagnato in parallelo tutte le varie evoluzioni del manifesto, senza mai conoscere crisi. Campagne pubblicitarie pubbliche al fine di giustificare invasioni, di veicolare i concetti della Guerra Fredda, di accompagnare i cittadini in scelte referendarie, di sponsorizzare campagne elettorali, saranno solo alcuni aspetti della diffusione del manifesto politico per tutto il XX Secolo.
Facciamo ritorno al 1945 e ai poster prettamente pubblicitari. Se gli anni Cinquanta stabiliranno i presupposti per un nuovo metodo comunicativo e la tecnologia di stampa conoscerà la diffusione massificata dell’offset (la tipografia industriale con cliché a ciclo stampa continuo con rotoliti), saranno gli anni Sessanta a divenire la seconda grande Golden Age del affiche.Creato a partire dagli anni venti, il concetto di “slogan” conobbe l’apice del successo proprio nei favolosi Sixties, decennio in cui la porzione di testo divenne elemento indissolubile e imprescindibile di ogni campagna pubblicitaria. In Italia fu pioniere il motto “E’ sempre l’ora dei Pavesini” dell’artista “fluxus” Erberto Carboni cui fecero seguito slogan di ogni sorta accompagnati da personaggi, illustrazioni, disegni, qualsiasi cosa potesse inserirsi nel contesto visivo del manifesto stesso. L’Italia fu all’avanguardia in questo periodo raccontando per immagini il “boom” economico con grande poesia e simbolismo: stiamo parlando della creatività di Armando Testa e del suo studio – lo “Studio Testa” – con le sue campagne iconiche che hanno attraversato non solo i manifesti ma qualsiasi media disponibile al tempo.
Negli USA si affermano, tra gli anni Sessanta e Settanta, i più grandi pubblicitari di ogni tempo, anche in questo caso mescolando l’arte pittorica e la fotografia alla comunicazione. Di nuovo, artisti di caratura internazionale si prestano con grande passione al mondo del poster, esaltando alcune caratteristiche peculiari delle correnti artistiche di riferimento: è il caso della Pop Art di Andy Warhol e Man Ray, così come dell’iperrealismo fotografico di Helmut Newton e via discorrendo.
Straordinario interprete del periodo d’oro del “advertisement” e nome unico in tutta la scena mondiale è Milton Glaser, l’illustratore newyorchese che creò l’eterno I Love New York sostituendo la parola “love” con un cuore e che mise la firma su alcune tra le campagne pubblicitarie più rilevanti del Secolo.
Con l’avvento degli anni Ottanta si registra un drastico cambiamento nel mondo della cartellonistica a causa dello sviluppo della grafica e della stampa digitale. Al pari di ciò, il manifesto viene lentamente soppiantato dalle pubblicità televisive che negli Eighties conoscono il loro momento d’oro, ma nonostante le avversità dettate dal progresso, il manifesto manterrà fino alla fine del Secolo – e anche dopo – la sua dignità e soprattutto la sua insostituibile funzione.
Loghi modernissimi, realizzazioni in 3D, fotografie punk, slogan bizzarri, nudità e violenza, umorismo macabro e grande rottura della “quarta parete”: la comunicazione degli anni Ottanta e Novanta cambia drasticamente la sua connotazione “buona” e armoniosa per concentrarsi sullo stato di shock da instillare nel pubblico.
Osare e innovare in un momento in cui il Capitalismo raggiunge le massime vette e l’arte di vendere e di vendersi diventa l’unico metodo per sopravvivere nella giungla urbana. In questo contesto mantiene salda la posizione un artista come Glaser che man mano lascerà spazio alle agenzie più in voga d’America e a artisti di rottura come Keith Haring o Folon. -
Contenuti // Sviluppo
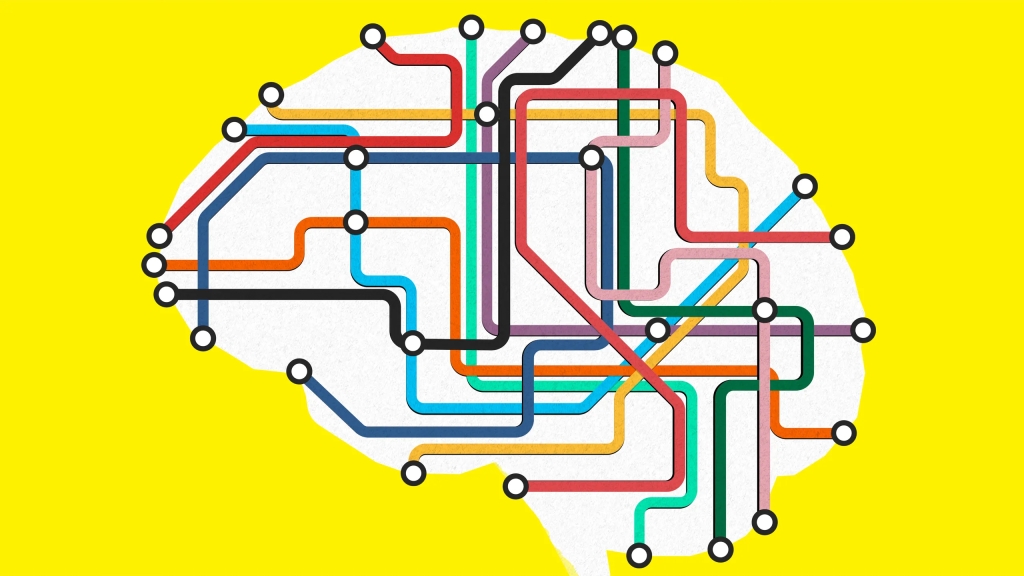
Studio; capacità di comunicazione; abilità nella scrittura = identità, sviluppo e nuove opportunità d’impresa.
Una sintesi stringata per un’equazione che è stata confermata da e nel tempo. Ma è possibile sintetizzare ancora di più e ottenere un concetto chiaro? Certamente!
La creazione e la scelta di contenuti professionali da usare per un’impresa (da micro a grande) mette in atto un cambiamento radicale nell’impresa stessa. Questo è il concetto esatto, più o meno. (Nota: chi scrive non sta usando l’AI ☺) .
Per cui viene da chiedersi, qual è la figura professionale che si occupa di questo?
In realtà se vogliamo essere onesti è un lavoro che – se inteso seriamente – deve essere svolto in team, perché le competenze che occorrono sono davvero molte. Si può comunque senza ombra di dubbio affermare con termini calcistici che il centravanti di questo specifico lavoro è il content strategist, ovvero colui che sceglie tra tutta una serie di contenuti (sì, proprio come lo showrunner per le serie tv) – finalizzando tale selezione per una specifica attività imprenditoriale – qual è il più adatto e dove pubblicarlo.
Già, perché un contenuto può essere adatto per una piattaforma social e per un’altra no (oppure va modificato), può andar bene per un articolo su un sito web ma non per altro etc…Molte volte il content strategist crea egli stesso i contenuti quindi ricopre anche la mansione di un content creator. Spesso dunque lo stratega e il creatore sono la stessa figura professionale. Egli dovrà in ogni caso consultarsi con altri specialisti in altre materie appartenenti allo stesso staff per realizzare un lavoro al massimo delle loro capacità sinergiche e per far ottenere al loro cliente il miglior risultato. La storia del calcio ci insegna che se un centravanti non riceve gli assist dalla sua squadra non segnerà mai un gol, o quasi… . Ecco perché senza il confronto non potrà mai esistere un lavoro svolto professionalmente. E vi assicuro che accade proprio così.
Il contenuto e la comunicazione sono fondamentali per far nascere e funzionare un rapporto che mira alla fidelizzazione tra brand e clienti. Internet è “l’autostrada” accessibile a tutti, che ha stravolto il metodo di fare impresa. Un piccolo esempio: un negozio di provincia, con buoni prodotti, può avere crescite che non avrebbe mai immaginato sotto vari aspetti, uno su tutti il suo fatturato.
In sostanza a questa figura professionale è affidata la gestione di cosa pubblicare online, quando e su quale piattaforma. Tutto questo per curare al meglio il brand e un’immagine che segua una linea “editoriale” ben precisa in modo da apportare valore aggiunto all’azienda cliente e di conseguenza aiutarla anche a crescere.
E’ ormai consolidato che senza contenuti adatti, con uno standard d’immagine alto, puoi spendere quanto vuoi in campagne promozionali sui social o sui siti web ma non avrai nessun risultato; questo semplicemente perché l’efficacia è data dalla professionalità della gestione di tutto l’insieme.
Il sito web e i social aziendali rappresentano il biglietto da visita di ogni brand e il principale canale attraverso il quale si relazionano con i propri clienti nel mondo 4.0. . Ecco perché scegliere di collaborare e compiere un percorso facendosi guidare e coinvolgere da uno o più digital creators e/o content strategists di talento può fare indubbiamente la differenza. Prestare sempre attenzione ai “cuggini” o ai non professionisti della comunicazione poiché purtroppo buttereste i vostri soldi ricevendo effetti negativi nel caso peggiore o nessun risultato nel caso migliore.
-
Una mamma sana nella mente e nel corpo

Oggi ricorre la Festa della Mamma, celebrata ovunque per il suo coraggio, la sua tenacia, il suo amore incondizionato. Celebrata dai figli di tutto il mondo, è occasione indiscussa di lucro per milioni di aziende che propongono in questi giorni regalie di ogni sorta. La figura materna è, storicamente, un lungo viaggio nel sentimento e nel coraggio, attraverso millenarie leggende, storie quotidiane di vita vissuta, progresso e scienza. Quando si pensa ad una madre non possiamo far altro che indugiare col pensiero a una figura densa di coraggio; ciò è indubbiamente vero ed è corretto ricordare la mole gargantuesca di energie che una mamma sa, per natura, convogliare per amor dei figli.
Ma nel 2023, nel bel mezzo di una delle più grandi crisi economiche e di coscienza che il Mondo abbia mai conosciuto, forse è necessario porre l’accento della questione sulla fragilità delle mamme.
Perché le mamme sono esseri umani; sono fallaci; sono soggette alle intemperie della vita come chiunque altro. E oltretutto assorbono i dolori dei figli, come principale fonte di erosione mentale e fisica. Essere mamma significa esserlo da giovani, da adulte e da anziane; significa esserlo di giorno e di notte; significa esserlo con figli vicini e lontani; significa rimanere mamma anche dopo aver elaborato il lutto di un figlio. Ed è noto quanto sia impossibile sopravvivere alla propria progenie.
Ogni passo che una madre compie, lo compie con il doppio, il triplo dello sforzo. E questo non giova alla sua salute mentale. Se consideriamo che è usanza comune dare per scontato il fatto che una mamma ce la possa fare, per tutta una serie di stereotipi, la verità invece non si cela affatto e rimane lampante sotto ai nostri occhi: una mamma ha una salute mentale messa a durissima prova quotidianamente.La giornata di una madre difficilmente coincide con le esigenze di un figlio eppure l’essere umano donna si adatta, forzando il proprio ciclo circadiano e il proprio orologio biologico, alla ricerca di quel tanto di linfa che basti ad alimentare lo sviluppo e la crescita di un bambino.
Se ripercorriamo le tappe della maternità, possiamo scoprire quanta violenza e trauma esse incontrino.
La gestazione: il peso che aumenta; le notti insonni; la nausea; l’aspetto che si trasfigura; la mancanza o il troppo appetito; il mal di schiena e l’incubo che ad ogni esame qualcosa nel bimbo che portano in grembo possa andare storto.
Impossibile soltanto immaginare il dolore lancinante e distruttivo che possa scatenare la scoperta di una malattia genetica nel figlio prossimo venturo.
Il parto: il fenomeno della “violenza ostetrica”; la sofferenza fisica; la confusione ormonale; il momento dell’apice subito prima che il figlio venga alla luce.
Il neonato: altre notti insonni; ancora gli squilibri ormonali; l’allattamento e il rischio di mastite e altre dolorose complicazioni; il fisico travolto e sconvolto che deve tornare in ordine; l’empatia totale con ogni singolo pianto del proprio piccolo; l’ansia; la depressione; la sensazione di sbagliare tutto; la certezza di non saper affrontare il domani; e ancora l’ombra, lo spettro, di rare patologie non scoperte.
Il bimbo piccolo: distorcere e adattare i propri orari; veder crescere troppo velocemente il proprio figlio; educare, una missione impossibile; sensibilizzare e capire; comunicare; inevitabilmente iniziare a ferire e a venire feriti proprio da chi è parte di noi; far coincidere il lavoro, la vita privata, la sfera intima, il proprio tempo, con l’unica nuova ragione di vita.
L’adolescente: l’innocenza che se ne va; il dubbio atroce di aver sbagliato tutto; le compagnie sbagliate; sentirsi rinfacciare soltanto di averlo messo al mondo; i sensi di colpa; gli anni che passano sulle proprie gambe e le energie che cominciano ad esaurirsi; la resistenza estenuante ad ogni tragedia messa in atto dagli ormoni, stavolta quelli del figlio; le notti in bianco non sapendo dove sia; la rabbia ma soprattutto la gestione della rabbia.
Il figlio grande: la sindrome del nido vuoto; il tempo che passa; sentire che la propria necessaria utilità come madre sta volgendo al capolinea; l’indipendenza economica di un figlio e quale futuro assicurargli; il mondo del lavoro e la piaga di una crisi senza precedenti di cui una madre si sente ingiustamente responsabili; i conti da far quadrare; i primi acciacchi di vecchiaia; il dolore di dover essere la madre, stavolta, a dover chiedere aiuto al figlio; un figlio sempre più lontano; e guardarlo con orgoglio andare incontro alla vita, capendo finalmente che nonostante tutto, la mamma ha fatto proprio un capolavoro.Tutto questo è praticamente una parte infinitesimale e soltanto abbozzata di quanto una madre subisca durante l’arco della sua vita. La maternità è la prova mentale e psichica più grande di tutte e non merita soltanto un immenso rispetto, ma necessita di cura e controllo, attenzione massima e presenza. Una madre deve poter chiedere aiuto e rivolgersi alle giuste figure professionali e ai giusti riferimenti umani. Una madre non deve mai rimanere da sola.
by nemesi
Spazio di approfondimento culturale
